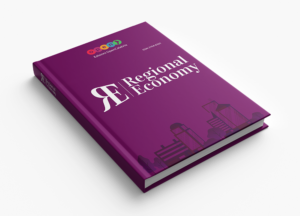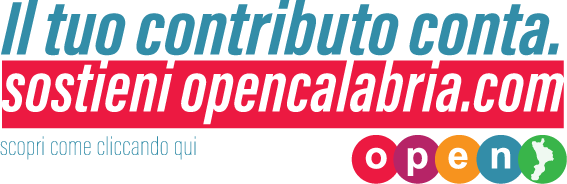Questo testo è incluso nel volume Giovanni Anania. Un economista civile, pubblicato da Donzelli nel 2025 e curato da Roberto Fanfani, Fabrizio De Filippis, Margherita Scoppola e Mimmo Cersosimo. Il libro raccoglie contributi scientifici e personali che restituiscono la statura intellettuale e umana di Giovanni. Il mio capitolo è un ricordo intrecciato alla mia formazione accademica e al debito intellettuale che conservo nei suoi confronti.
Nel corso di una carriera accademica, capita di incontrare docenti brillanti, ma raramente si ha la fortuna di imbattersi in figure capaci di unire competenza scientifica, integrità morale e responsabilità educativa. Se dovessi oggi delineare, con la distanza critica che l’esperienza consente, il profilo di un docente ideale, direi che è colui che coniuga rigore metodologico e chiarezza espositiva, empatia e capacità di ascolto. Un docente che non si limita a “trasmettere contenuti”, ma che insegna a formulare problemi, a difendere argomentazioni, a coltivare il dubbio come risorsa intellettuale. Ancora più raro, però, è incontrare un mentore autentico. Un mentore ti riconosce prima che tu sappia di meritare riconoscimento; ti offre opportunità, ma ti lascia lo spazio per decidere se e come coglierle e ti accompagna nella costruzione di un’identità scientifica. È qualcuno che vede in te ciò che potresti diventare, e agisce, in modo discreto ma costante, affinché tu ci arrivi con i tuoi tempi e le tue forze.
Giovanni ha incarnato per me entrambe queste due figure: il docente ha segnato in modo decisivo la mia formazione e il mentore ha creduto nel mio percorso accademico prima ancora che io riuscissi a immaginarlo. Lo è stato fin dai primi incontri. Il primo risale alla tarda primavera del 1987, nell’aula 41 del Dipartimento di Economia Politica dell’Unical. Giovanni era appena rientrato da Davis, dove aveva conseguito il PhD. In Facoltà sentivo spesso parlare con entusiasmo di questo ex studente del corso di laurea in Scienze Economiche e Sociali, che si apprestava a tenere un seminario sugli effetti distorsivi delle politiche agricole sui guadagni dal commercio internazionale. Realizzate con Colin Carter e Mary Bohman e presto pubblicate sull’American Journal of Agricultural Economics, queste ricerche avviarono un dibattito duraturo. Spinto dalla curiosità andai ad ascoltarlo. Ricordo perfettamente la sala gremita di docenti e di qualche laureando. Io ero anonimamente seduto in fondo all’aula. Bastarono dieci minuti per restare colpito. I suoi lucidi erano ordinati con una precisione meticolosa: sovrapponeva fogli e utilizzava colori distinti per rappresentare spostamenti di curve di domanda e offerta e per mostrare gli effetti di politiche in scenari differenti. Era una costruzione visiva del ragionamento, passo dopo passo, che rendeva tangibile la complessità senza mai confondere; la voce di Giovanni era ferma, autorevole, con un timbro inconfondibile che incuteva un certo timore, ma anche una curiosa familiarità. L’accento catanzarese, tra voci che spesso suonavano distanti e impersonali, mi sembrava quasi un invito a prestare attenzione.
Qualche settimana dopo, incontrai Giovanni in qualità di membro della commissione d’esame di Economia Internazionale tenuto da Antonio Aquino. Era il mese di luglio del 1987. Avevo appena superato lo scritto ed ero pronto ad affrontare l’orale. La sessione era affollata, l’aula Circolare traboccava di studenti. Fu proprio Giovanni a interrogarmi. Portavo con me squadrette e un assortimento quasi infantile di penne di ogni colore: un rito contro l’ansia d’esame. Quando mi sedetti Giovanni disse qualcosa sul perché avessi con me tutte quelle penne. Cercai di mascherare l’agitazione con una risposta tecnica, accennando al fatto che potevano servire per tracciare i grafici. Sfogliò l’elaborato scritto e mi chiese di illustrare gli effetti di una tariffa sulle importazioni. Tentai timidamente di orientare l’interrogazione, domandando se volesse un’analisi in equilibrio economico parziale o generale. Lasciò a me la scelta. L’interrogazione durò mezz’ora. Una sequenza ininterrotta di domande. Giovanni teneva le braccia conserte, senza un sorriso, senza un gesto d’approvazione. Solo domande, domande, domande. Era estenuante, ma avvincente. Avevo la netta sensazione che non stesse cercando la risposta giusta, ma la traiettoria del mio ragionamento. I fogli di carta si riempivano di grafici multicolore. Alla fine, Giovanni chiamò Antonio. Scambiarono qualche parola sottovoce, poi fu Antonio a comunicarmi il voto. Quando strinsi la mano a entrambi, Giovanni mi guardò e disse semplicemente: bravo. Antonio annuì.
Dopo l’estate, senza esitazione, sostituii un esame opzionale per inserire Economia Montana e Forestale, che in quell’anno era tenuto da Giovanni. Fu una scelta che si rivelò decisiva, perché mi aprì prospettive che ignoravo. Mi innamorai della materia e della dimensione analitica con cui Giovanni la presentava, tant’è che in quel semestre il mio interesse per l’economia esplose letteralmente. Giovanni fu l’interprete principale di questo cambiamento. Durante il corso, organizzò due visite aziendali. Una, memorabile, si svolse presso due aziende suinicole della Sila Greca. Fu la prima occasione di confronto tra la teoria con la realtà produttiva in un contesto marginale. Un’esperienza intensa, che lasciò un’impronta profonda sul mio modo di intendere il legame tra analisi economica e osservazione empirica. Quel corso è rimasto, nel tempo, il mio personale riferimento ideale di cosa significhi insegnare con passione, rigore e chiarezza, stimolando dubbi e curiosità. Un esempio che, pur con la consapevolezza delle distanze dal mio Maestro, continuo a considerare un modello nella mia esperienza di insegnamento.
All’epoca la faculty del Dipartimento era di altissimo livello, ma in Giovanni mi colpivano alcune qualità che lo rendevano unico: l’entusiasmo contagioso con cui conduceva le lezioni, la chiarezza espositiva, la puntualità assoluta, la capacità di rendere comprensibili concetti complessi senza mai banalizzarli. La spinta propensione al confronto internazionale. Ma, soprattutto, amavo il rispetto con cui trattava gli studenti: per lui eravamo tutti apprendisti economisti, non semplici destinatari di contenuti. Affascinato dal suo talento, a metà semestre iniziai a pensare alla tesi. Chiesi consigli a vari docenti, ma Giovanni fu il primo a coinvolgermi in modo diretto. Nel nostro primo incontro mi diede una copia di “The Common Agricultural Policy and Less Developed Countries” di Alan Mattews, chiedendomi di leggere con attenzione le parti dedicate alle politiche di preferenza commerciale. Con il suo consueto tono essenziale mi disse di ritornare dopo aver studiato quei capitoli. Andai nel panico. Con l’ansia tipica degli studenti, temevo di non essere all’altezza: leggere materiale in inglese, in poco tempo, mi sembrava una sfida troppo ambiziosa. Ma decisi di provarci: mi immersi completamente nello studio, e finii per leggere l’intero libro, non solo le parti assegnate. Quando tornai da lui, la discussione si concentrò, come previsto, sulle politiche preferenziali. A un certo punto, Giovanni afferrò le fotocopie del libro che erano dense di annotazioni, e con tono neutro mi chiese se avessi letto tutto il volume. Gli risposi che avevo preferito capire meglio la PAC, anziché limitarmi agli accordi preferenziali. Non disse nulla. Ma nel suo silenzio colsi un segno evidente di soddisfazione.
Mi assegnò la tesi sul trattamento preferenziale che l’UE riservava alle esportazioni dei paesi firmatari della Convenzione di Lomè. Fu un’esperienza straordinaria. Giovanni mi seguiva con dedizione assoluta: abitando nel campus di Arcavacata, ci incontravamo ogni settimana alle 7:30 del mattino, prima che iniziasse la sua lezione delle 8:30. Una consuetudine che mi ha segnato sul piano dell’entusiasmo e della disciplina. Durante la parte empirica, avevo bisogno di dati del World Development Report, che in biblioteca erano disponibili, ma incompleti per alcune annualità. Giovanni scrisse direttamente a Alex McCalla, e poche settimane dopo arrivarono, via fax, decine di pagine di dati. Intasammo per ore il fax del Dipartimento. Fu un viaggio intellettuale appassionante, un’esperienza di crescita impressionante. Ricordo ancora l’emozione nel vedere quei dati arrivare da oltreoceano, su iniziativa del mio relatore. Giovanni fu soddisfatto del lavoro svolto. Tanto che ne pubblicammo alcuni estratti: la mia prima esperienza di “scrittura scientifica”, guidata da lui. Non potevo chiedere di più. Uno di questi estratti, a firma congiunta, fu presentato in un workshop organizzato a Positano da Fabrizio De Filippis. Giovanni mi portò con sé, introducendomi per la prima volta nel contesto accademico che fino ad allora avevo conosciuto solo attraverso le letture. Erano studiosi di cui avevo letto articoli, consultato libri, discusso modelli. Lì, in quella che per molti versi fu la mia “prima conferenza”, ebbe inizio la frequentazione di un vivacissimo gruppo di ricerca che avrei poi frequentato per due decenni. Quel viaggio resta indimenticabile. Partimmo da Arcavacata con la sua inseparabile Fiat Uno, insieme a Margherita, sua moglie, che mi accolse con un affetto quasi materno, riempiendomi di attenzioni per tutto il tragitto. Una donna squisita, di rara gentilezza, che ricordo con affetto profondo. Durante il viaggio, Giovanni mi suggeriva come impostare la presentazione e come gestire i tempi: ricordava gli errori commessi durante la discussione della tesi e mi spronava a evitarli. Quella notte dormii pochissimo. Sentivo che non potevo permettermi di deludere le aspettative di Giovanni. Non ricevetti elogi, ma nemmeno critiche crudeli. Da Giovanni era il segnale inequivocabile che la prova era andata come doveva.
Dopo Positano comunicai a Giovanni la mia intenzione di continuare a studiare e di valutare, con serietà, l’ipotesi di intraprendere la carriera accademica. Quella dichiarazione non era un semplice desiderio vago né una forma di riconoscenza nei confronti di un relatore che mi aveva aperto un mondo: era una scelta consapevole, sostenuta da una decisione concreta che avrebbe colpito molti, ma non lui. Pochi mesi dopo la laurea, infatti, fui selezionato dall’Istituto San Paolo. Un’opportunità reale, un “posto sicuro”, in banca, per di più. Ma rifiutai quell’offerta, con la lucidità e la fermezza di chi sente che la strada intrapresa ha bisogno di essere seguita fino in fondo. Avevo appena ricevuto l’ammissione al Centro di Portici e non avevo alcun dubbio su cosa scegliere. Agli occhi di molti fu una decisione irrazionale, uno scambio tra il certo e l’incerto. Ma per Giovanni fu un segnale chiaro. A Portici preparai una tesi sulle politiche commerciali di un paese importatore, in continuità tematica con il lavoro di laurea, ma con un respiro teorico più ampio. Giovanni fu un relatore attento, esigente, metodico, presente. Le riunioni per discutere i progressi, i suggerimenti bibliografici, i ragionamenti sul metodo: tutto contribuiva a far crescere in me una forma mentis sempre più affine a quella del ricercatore. Un passo alla volta, Giovanni mi trasmetteva un modo di lavorare che avrebbe potuto diventare, un giorno, la base per una carriera accademica.
Durante gli anni di Portici, si aprì una nuova fase del nostro rapporto: da relatore a mentore, da guida a co-protagonista di un percorso formativo che si arricchiva progressivamente di tappe sempre più impegnative e stimolanti. Giovanni non perdeva occasione per propormi esperienze di studio, approfondimento e confronto internazionale. Era parte della sua visione: la formazione di un giovane economista non poteva esaurirsi nei confini di un’aula o di un titolo di studio. Lui aveva studiato anche all’Università dell’Essex, e, com’era sua abitudine, aveva mantenuto nel tempo rapporti solidi con colleghi e istituzioni. Grazie a quelle relazioni, mi offrì la possibilità di partecipare, per tre estati consecutive, al Master in Social Science Data Analysis, un’esperienza formativa avanzata, che mi permise di consolidare competenze quantitative che sarebbero tornate preziose negli anni successivi. Non solo. Mi permise anche di frequentare un corso di cooperazione internazionale allo sviluppo presso l’Istituto Italo-Africano di Roma. In quell’occasione si superò: la borsa di studio tardava ad arrivare, e Giovanni si fece carico personalmente delle spese di alloggio, anticipando all’albergo il costo del pernottamento nella costosissima piazza Ungheria, a due passi dall’Istituito.
Durante il dottorato continuai a occuparmi di politiche commerciali, e Giovanni mi incoraggiò per trascorrere un periodo di studio presso il Dipartimento di Economia Agraria di Reading, dove insegnava Alan Swinbank, suo amico e collega. Anche in quel caso, Giovanni aprì la strada, fornì i contatti, sostenne la proposta, rendendo possibile un’esperienza che ampliò ulteriormente i miei orizzonti scientifici. La tesi di dottorato, che formalmente aveva come supervisore un docente di Napoli, fu, nella sostanza, il frutto di un confronto continuo con Giovanni. Dopo aver analizzato gli effetti del trattamento preferenziale previsto dalla Convenzione di Lomé, Giovanni mi incoraggiò a spingere oltre l’analisi, concentrandomi su un meccanismo quasi inesplorato all’interno di quell’accordo: lo STABEX, uno strumento per stabilizzare i proventi delle esportazioni dei paesi ACP. Era un tema di frontiera: poco studiato, metodologicamente complesso. A livello internazionale, erano pochissimi gli studiosi che se ne occupavano. Tra questi, Giovanni mi mise in contatto con Ronald Herrmann, dell’Università di Giessen, con cui iniziai a scambiare dati, idee, ipotesi di lavoro. Giovanni non si era mai occupato dello STABEX, né aveva un interesse di ricerca diretto per questo argomento. La mia era, per molti versi, una strada solitaria, anche perché a Napoli la supervisione era piuttosto flebile. Eppure, in quella solitudine intellettuale, Giovanni c’era sempre. La sfida che condividemmo fu quella di sviluppare un argomento che non era suo. Io però sapevo che avrebbe letto ogni capitolo con l’attenzione di sempre, che ne avrebbe commentato le tabelle, criticato le scelte metodologiche, avrebbe proposto alternative. Ed è esattamente quello che accadde. Quando, da Napoli, Reading o da Londra, tornavo a Cosenza, il momento più atteso era la visita nello studio di Giovanni, al primo piano del Cubo OC del campus di Arcavacata. Andavo da lui con la stessa frenesia con cui si chiede un parere a chi davvero può fare la differenza. Lo aggiornavo sugli avanzamenti del lavoro, discutendone con la tensione e il coinvolgimento di un seminario. E uscivo da quella stanza con nuove idee, nuove prospettive, nuovi punti di vista. Giovanni aveva la straordinaria capacità di cogliere il cuore del problema, anche quando non era uno specialista del tema. A volte le nostre discussioni si accendevano. Frequenti le grida. Eravamo entrambi molto convinti delle nostre posizioni, ostinati nel difenderle. Ma la tensione non era mai sterile: era parte di un confronto autentico, in cui il dissenso serviva a migliorare l’argomentazione e a testare la tenuta delle ipotesi.
Il ruolo di mentore di Giovanni non si concluse con il dottorato. Anzi, fu subito dopo che iniziò un’altra fase decisiva: quella della scrittura scientifica autonoma. Utilizzando la tesi di dottorato, iniziai a lavorare alla stesura di due articoli. Furono i miei primi lavori a firma singola, e non sarebbero mai stati completati senza la sua spinta, la sua vicinanza e il suo impegno nel revisionarli a fondo. Giovanni lesse tutte le bozze, le revisioni, le mie risposte ai referees, proponendo soluzioni, suggerendo modifiche nella struttura argomentativa, obbligandomi a riscrivere più volte le introduzioni, che giudicava scolastiche e poco motivazionali. Fu una vera palestra. E Giovanni, in quella palestra, era l’allenatore: rigoroso, competente, instancabile. Io eseguivo le sue indicazioni. In quegli anni ho imparato a scrivere come economista.
Poi arrivò il momento della verità. Fu bandito un concorso da ricercatore presso l’UniCal, con due posizioni aperte. Un’opportunità tanto desiderata quanto temuta. Giovanni, ancora una volta, non lasciò spazio all’incertezza. Mi motivò oltre ogni misura, preparando, peraltro, un programma di studio che oggi definirei spietato, ma che allora rappresentava la più grande dichiarazione di fiducia che avessi mai ricevuto. Mi consegnò una lista dettagliata di testi da studiare e mi regalò una copia del Tirole e del Romer, raccomandandomi di studiarli integralmente, senza trascurare nemmeno le note. Il tono era fermo, quasi imperativo, una voce che non ammetteva repliche, ma che trasmetteva certezze nel fatto che potessi farcela, se solo mi fossi spinto oltre i miei limiti.
Preparai quel concorso per un anno intero. Non ho mai studiato tanto in vita mia. Giovanni mi chiamava ogni settimana: voleva sapere come procedevano le letture, se avevo dubbi, se c’erano passaggi da chiarire. A ogni telefonata, un consiglio. A ogni incontro, un incoraggiamento. Era un’attività di mentoring regolare, silenziosa ma costante, che alimentava sempre fiducia. Poi arrivò il giorno della prima prova scritta. La traccia estratta dalla commissione era ostica, un tema marginale, appena sfiorato nei testi che avevo studiato con ossessione per un anno intero. Consegnai l’elaborato, ma uscii dall’aula con un senso di delusione profonda, perché temevo di non raggiungere il massimo nella valutazione. Andai subito da Giovanni. Appena entrato nel suo studio, crollai. Gridai contro me stesso, balbettando parole di disappunto e rimpianto. Poi piansi. Piansi a lungo. Un pianto incontenibile, liberatorio. Giovanni mi osservava in silenzio, visibilmente scosso, ma rispettoso della mia amarezza. Dopo qualche minuto, uscimmo a prendere un caffè, cosa rara per lui. Durante il tragitto, iniziò a parlare con calma, ma con decisione. Ogni volta che incontro una battuta d’arresto mi ritorna in mente il senso di ciò che mi disse in quell’occasione: il valore di una persona non si giudica da una singola prova, ma dall’impegno che l’ha preceduta e dalla capacità di reagire. Il giorno dopo sostenni la seconda prova scritta. Questa volta la svolsi in modo eccellente. Tornai nel suo ufficio con un sorriso appena accennato, di quelli che non cercano approvazione, ma condividono un’intesa. Giovanni mi accolse con un’espressione compiaciuta, e non servirono parole.
Quel concorso segnò la fine di un ciclo. Ma nei vent’anni successivi, Giovanni continuò a essere una presenza autorevole e generosa, l’esempio concreto di come si possa coniugare ricerca, didattica e responsabilità pubblica.